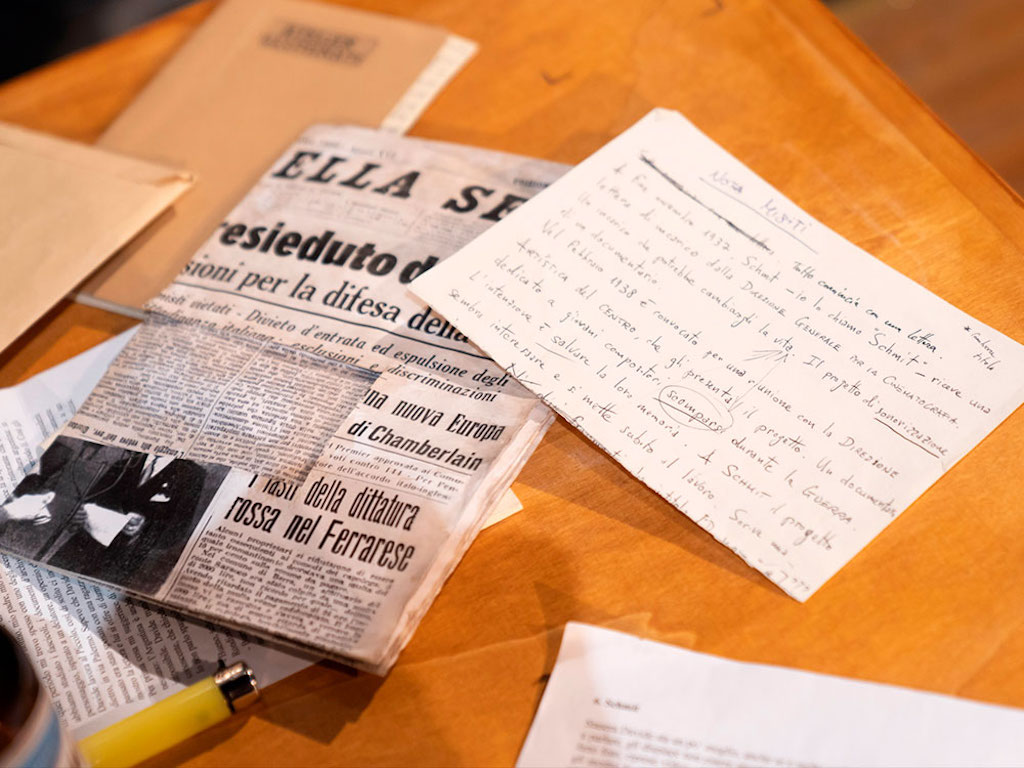Contro l’unicum zarista: la battaglia del senso nelle “Tre sorelle” di Muta Imago
Muta Imago opera una profonda e ispiratissima riscrittura del penultimo capolavoro di Anton Cechov, “Le tre sorelle”, dramma crepuscolare popolato dai fantasmi di carne della crème dello zarismo decadente, militari, nobili, passacarte. E da Maša, Olga e Irina, tre giovani donne orfane dei genitori (del padre da un anno) che cercano di trovare un senso, ovvero una direzione alla loro vita, e un appiglio materiale.
“Tre sorelle”, la riscrittura di Claudia Sorace e Riccardo Fazi vista alla Triennale di Milano nel contesto di FOG 2024, è frutto, a loro scrivere, di un procedimento alchemico drammaturgico “per sottrazione“, per giungere all’essenziale della pièce cechoviana. Una sorta di fusione fredda per arrivare al noyau della sua poetica. In scena ci sono solo le tre sorelle, quindi, che parlano per tutti gli altri personaggi, solo evocati. Il tempo, o meglio la temporalità della pièce, è plurima: c’è l’inseguimento affannoso a una linearità positivista, a una vita ancora da vivere con scelte e possibilità, e poi c’è il buco nero di un presente eternizzante, figlio del lutto.

I due tempi sono in conflitto, e innescano modi opposti di vedere le cose mentre nella lotta accade anche una terza temporalità, innescata dallo scontro: la fissità della perdita, della lacerazione, del presente imploso che risucchia la vita, e porta all’oscurità demonica si alterna fragorosamente col “tempo della vita”, l’anelito alla rinascita e al progresso che spinge a vedere nella moltitudine multicolor della capitale, Mosca, il culmine del tragitto esistenziale e dei possibili. Senza voler complicare, questa terza temporalità è quella più autentica delle tre sorelle, ed è irriducibile, inspiegabile, misteriosa e germinale: è il senso che sgorga come un magma che non può essere cristallizzato in una risposta ma risuona solo nella domanda, nel punto interrogativo (“perché siamo al mondo, perché soffriamo… ah saperlo, saperlo!”).
La realtà delle tre sorelle è dunque uno stridente campo di battaglia tra esperienze del tempo differenti, ben orchestrato dal sound design di Fazi, superbamente eseguito live da Lorenzo Tomio. Una battaglia tra temporalità diverse e modi di vedere antitetici. E qui sta, a nostro avviso, l’attualità eccezionale della poetica cechoviana, colta perfettamente dalla potenza della riscrittura di Muta Imago. Il nostro mondo è intriso di queste dinamiche conflittuali, dentro alla persona e fuori nella società. Anche noi siamo travolti da questa tempesta di temporalità (quella del buco nero, del lutto nella pièce, corrisponde alla vanitas, all’effimero della Medusa che seducendo paralizza), e non c’è alcun senso reperibile che non sia lì nel conflitto stesso.
Il mondo in rovina cechoviano era quello di una società, quella russa di fine Ottocento, che non si reggeva e non si affidava più alla visione imperiale. E qui si apre l’exitu. Ovviamente lo zar è un uomo così come lo sono i militari e i burocrati. Il potere zarista è maschile, ovvero univoco. Le tre sorelle si dibattono per provare a far parte ancora di quel mondo, ma il loro conflitto le porta a incarnare femminilmente un parto psicologico, un’aurora e una divergenza, una falla plurima che minaccia la visione zarista univoca.

Muta Imago allestisce una quinta scenografica che evoca un interno borghese fin de siècle, ma le tre sorelle sono sia di quell’epoca che di molte altre. In scena c’è un telefono a filo, una radio degli anni Ottanta, delle palle luminose portatili. Da qui i MI attingono a tutti i loro studi e al loro complesso linguaggio scenico – danza meccanica, suoni e musiche cosmogoniche o liriche, impianto luci totalizzante: il tutto potente come e più dei personaggi – per teatralizzare lo scontro tra vecchio e nuovo mondo, tra univocità e multivocità.
E trovano nella tiepida e malinconica resilienza finale (parolaccia, avete ragione) delle sorelle la chiave dell’exitu. Ma le loro grida, i risvegli dagli incubi, i sogni tormentati, le visioni, le illusioni, sono le stesse che riecheggiano nel nostro mondo devastato dalle guerre e dal tecnoconsumismo che non lascia spazio all’interiorità (la vera natura della privacy) e alla ricchezza interiore delle persone: questo è in sostanza il nuovo campo di battaglia del Millennio, con i brand che spolpano l’individuo, impossibilitato a esistere in quanto tale, soffocato dalla potenza univoca e annichilente della merce che uniformizza tutto e tutti.

In Tre sorelle l’esteriorità è zarista, univoca e bellicista – l’interiorità cechoviana riletta da IM e abitata un tempo dalle donne, è invece uno specchio distorto degli interni borghesi che disturba e inquieta la visione zarista: la (nuova) realtà è data dallo scontro tra questi orizzonti. Per questo l’exitu di tre sorelle non è squisitamente femminista. Le parole di Cechov sul tempo che ci cancellerà sono dell’uomo come specie e in particolare dell’homus europeus.
Tre sorelle di Muta Imago tirando le fila è solo il capitolo di un conflitto ancora da combattere per impedire che l’alienazione ci trasformi in nuovi fantasmi post-zaristi, simulacri di un potere che non è nelle nostre mani ma in quelle di poche persone che stanno alienando la vita vera ai vacui paradisi tecnoartificiali. E nelle grinfie dei nuovi zar che provano a reimporre un giogo imperiale ante litteram.

Muta Imago
Tre sorelle
di: Anton Cechov
regia: Claudia Sorace
drammaturgia e suono: Riccardo Fazi
con: Federica Dordei, Monica Piseddu, Arianna Pozzoli
musiche originali eseguite dal vivo: Lorenzo Tomio
disegno scene: Paola Villani
direzione tecnica e disegno luci: Maria Elena Fusacchia
costumi: Fiamma Benvignati
amministrazione, organizzazione e produzione: Grazia Sgueglia, Silvia Parlani, Valentina Bertolino
comunicazione: Francesco Di Stefano
ufficio stampa: Marta Scandorza
una coproduzione di: Index Muta Imago, Teatro Di Roma – Teatro Nazionale, Tpe – Teatro Piemonte Europa In Collaborazione con Amat & Teatri Di Pesaro Per Pesaro 2024. Capitale Italiana Della Cultura / foto di scena: Luigi Angelucci, Gaia Adducchio
durata: 75’


 Ma il vero fulcro della drammaturgia, come scrive lacasadargilla nelle note, è lavorare sulle pastoie del desiderio, e sulla solitudine come suo sintomo manifesto. Siamo soli perché non sappiamo più i nostri desideri. Non avendo dei desideri “reali”, il corpo desiderante trascende lacanianamente in un set terapeutico analitico sui generis, perché non c’è nemmeno un evidente désir di guarigione nei personaggi. Ancora una volta Kafka, i cui personaggi sono tutti lacerati da desideri latenti e sommersi, che affiorano saltuariamente in maniera distruttiva.
Ma il vero fulcro della drammaturgia, come scrive lacasadargilla nelle note, è lavorare sulle pastoie del desiderio, e sulla solitudine come suo sintomo manifesto. Siamo soli perché non sappiamo più i nostri desideri. Non avendo dei desideri “reali”, il corpo desiderante trascende lacanianamente in un set terapeutico analitico sui generis, perché non c’è nemmeno un evidente désir di guarigione nei personaggi. Ancora una volta Kafka, i cui personaggi sono tutti lacerati da desideri latenti e sommersi, che affiorano saltuariamente in maniera distruttiva.